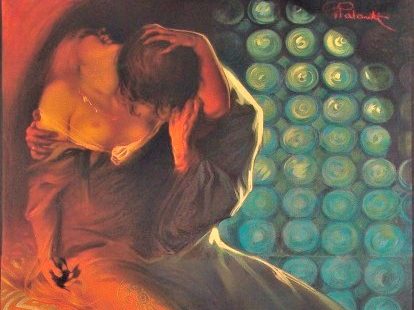
“Francesca da Rimini”, il ritorno alla Scala dopo 59 anni. La storia affascinante di D’Annunzio e il teatro in musica (di Fulvio Venturi)
di FULVIO VENTURI
“Ma sol vidi una rosa
che mi si offerse più viva che il labbro
d’una fresca ferita”
(Gabriele d’Annunzio, Francesca da Rimini, atto secondo)
Il ritorno di “Francesca da Rimini” alla Scala, teatro dal quale era assente da cinquantanove anni (l’ultima produzione si tenne nel maggio-giugno 1959, auspice Gianandrea Gavazzeni) ci offre l’estro per compiere una ricognizione sul teatro di Gabriele d’Annunzio in musica (in cartellone sul palcoscenico scaligero fino al 13 maggio 2018, ndr). Non che l’argomento sia inedito, esiste, da anni, un libro-saggio di Rubens Tedeschi al riguardo, ma il favore incontrato dall’attuale produzione, e l’attesa creatasi attorno ad essa, ci induce a questa piacevole fatica. Innanzitutto avrei voglia di aprire una (s)garbata polemica sul fatto che un’opera come quella di Riccardo Zandonai abbia avuto nel massimo teatro italiano sette produzioni fra il 1915 ed il 1959, dunque in quarantaquattro anni e neanche una nei seguenti cinquantanove fino ad oggi. Perché le opere dannunziane sono state rappresentate solo col favore del regime fascista mi si potrebbe rispondere. Non diciamo sciocchezze per cortesia. “Francesca da Rimini” è stata ed è un’opera molto rappresentata ed amata da prime donne di rango quali Magda Olivero, Raina Kabaivanska, Renata Scotto, Ilva Ligabue, Marcella Pobbe che l’hanno portata in scena ben dopo il fascismo. Semmai ci sarebbe da riflettere sui motivi per i quali, quando l’opera di Zandonai fu allestita al Metropolitan di New York nel 1984 con una cast stellare (Scotto, Domingo, McNeil; Levine direttore) la dirigenza scaligera di allora non abbia proceduto ad una coproduzione che sarebbe stata epocale: l’opera rimase in cartellone al Met fino al 1990 ed è stata “ripresa” cinque anni fa.
Ma torniamo all’argomento: D’Annunzio e il teatro in musica.
Le opere teatrali che mettono in musica testi di Gabriele d’Annunzio sono sette e riguardano “La figlia di Iorio”, composta da Alberto Franchetti (1906) e Ildebrando Pizzetti (1954), “Parisina” da Pietro Mascagni, “Francesca da Rimini” da Riccardo Zandonai, “Fedra” da Ildebrando Pizzetti, “La Nave” da Italo Montemezzi, “Sogno di un tramonto d’autunno” da Gianfrancesco Malipiero. Ad esse si devono aggiungere le musiche di scena per “Le Martyre de Saint Sébastien” di Claude Debussy e quelle per “La Nave” e “La Pisanelle” ancora di Ildebrando Pizzetti e almeno un’opera inultimata “La Ville Morte” di Nadia Boulanger e Raoul Pugno, il cui testo altro non è che la traduzione francese de “La città morta” (1897).
La prima rappresentazione de “La figlia di Iorio” di Alberto Franchetti ebbe luogo alla Scala il 22 marzo 1906 con tutti i crismi dell’avvenimento e con una grande attesa. Si trattava della prima opera che metteva direttamente in musica un testo teatrale di Gabriele d’Annunzio la cui fama, dopo il 1903, anno in cui dette alle stampe la silloge di “Alcyone” e il 1904, quando proprio la versione poetica e teatrale della “Figlia di Iorio” era apparsa sulle scene (Milano, Teatro Lirico, 2 marzo 1904, con Irma Gramatica e i “décors” di Francesco Paolo Michetti) era diventata universale. Tuttavia l’opera di Franchetti non piacque e Carlo Gatti, futuro direttore artistico del “massimo” milanese ebbe a notare che ”la musica di Franchetti è piuttosto lontana dall’aggiungere bellezza al bellissimo suono della poesia dannunziana, e tanto meno efficacia all’espressione sentimentale potentissima nella tragedia. Non c’è in essa quella semplicità primitiva (…) e quel sentore di terra vergine ritratto impareggiabilmente dal poeta”. Ma se questa “Figlia di Iorio” di Franchetti può essere considerata un esperimento mal riuscito di sparuto riscontro critico e popolare, non sarà così per i titoli a venire.
Ad alzare la qualità musicale ci pensò Claude Debussy con le musiche di scena per il “Martyre de Saint Sébastien”, il primo testo in lingua francese uscito dalla penna di Gabriele d’Annunzio dopo il volontario “esilio” in terra di Francia (in realtà, diciamocelo, fu una fuga per debiti).
Testo alato, forbitissimo, redatto in una francese tanto esemplare quanto anticato e sofistificato, del quale la sola “dédicace” a Maurice Barrès, fratello simbolista francese di d’Annunzio, basterebbe a far gridare al capolavoro.
Fu lo stesso Vate, da sempre ammiratore della musica di Debussy a rivolgersi al musicista francese con una lettera da Arcachon del 25 novembre 1910, nella quale, oltre alla proposta di collaborazione, il poeta parlava de “cette oeuvre” (il suo Saint Sébastien) “et de ce reve” (i commenti musicali di Debussy).
Il musicista accettò non senza riluttanza, poi prese passione al progetto e addirittura interagì con D’Annunzio stesso proponendo sedi diverse da quella parigina, Boston ad esempio, per la prima rappresentazione della loro opera.
Musicalmente ne uscì fuori un lavoro ampio, al quale André Caplet collaborò per la strumentazione, per orchestra, coro e voci femminili soliste. “Le martyre de Saint Sébastiern” andò in scena il 22 maggio 1911 al Théatre du Chatelet sulla Rive Droite. I due artisti pensarono poi di ampliare addirittura la parte musicale, progetto del quale esistono tracce epistolari fino al 1914, senza addivenire alla conclusione.
Tuttavia, sempre in accordo con D’Annunzio, Claude Debussy preparò una versione da concerto delle sue musiche collegate da estratti del testo dannunziano. Versione mirabilissima e indimenticabile per chi abbia avuto la fortuna di assistere ad una sua esecuzione concertistica, come è accaduto a me (Teatro alla Scala, ottobre 1977, Georges Pretre, orchestra, coro, voci soliste e attori della Comédie Francaise) per una delle più appaganti esperienze concertistiche della mia lunga carriera di spettatore.
Ida Rubinstein, l’affascinante danzatrice russa che già era stata ispiratrice del “Martyre” fu la Ninfa Egeria anche della successiva operazione dannunziana in lingua francese, “La Pisanelle, ou La mort parfumée”, che andò in scena ancora allo Chatelet il 12 giugno 1913. In questo caso Gabriele d’Annunzio (in basso a destra in una tela dipinta da Romaine Brooks) scelse come collaboratore musicale Ildebrando Pizzetti che già nel 1908 aveva composto sette pagine corali per la prima rappresentazione di quel grande affresco medievale che fu “La Nave” (Roma, Teatro Argentina, 11 gennaio 1908). Pizzetti, la cui composizione monodica non si sovrapponeva alla musicalità del verso dannunziano, compose per “La Pisanelle” dieci brani che successivamente avranno una dignitosa vita concertistica come suite a se stante e faranno parte del repertorio di grandi direttori d’orchestra.
Il 1913 e i due anni successivi furono decisivi per il teatro dannunziano in musica poiché in tempi molto serrati tre opere come “Parisina” di Mascagni, “Francesca da Rimini” di Zandonai e “Fedra” di Ildebrando Pizzetti videro la luce.

Alla base dell’iter che portò alla nascita di “Parisina” vi fu il classico colpo di fulmine. Mascagni lesse la tragedia che con “Francesca da Rimini” e il mai redatto “Sigismondo” doveva completare la triade dei “Malatesti” e se ne innamorò. In tempi rapidi fece stringere l’accordo fra il suo editore Lorenzo Sonzogno e D’Annunzio ed iniziò a comporre. Il primo brano che uscì dalla sua tastiera fu l’assolo di Ugo d’Este “Or voi composto m’avereste nella bara” che rimarrà una sorta di icona sonora dell’opera quindi informò D’Annunzio che avrebbe voluto comporre l’opera stando al suo fianco. E pensare che i rapporti fra il livornese ed il pescarese non erano stati sempre cordiali in ragione della stroncatura che D’Annunzio aveva esteso all’apparire di “Cavalleria rusticana” e “L’amico Fritz”.
Mascagni dunque affittò una villetta nei pressi di Parigi e là si trasferì sotto mentite spoglie. La composizione di “Parisina” ebbe luogo per tutto il 1913. Mascagni lavorò con straordinario entusiasmo, dando forma compiuta a tutto quello che aveva sperimentato con “Amica” (1905) ed “Isabeau” (1911). “Parisina” andò in scena il 14 dicembre 1913 al Teatro alla Scala gremito in ogni ordine di posti ed al cospetto di alte personalità. Ancora una volta l’evento fu preparato con dovizia di particolari artistici. Quattro tavole di Gaetano Previati, tratte da quattro quadri ad olio ispirati dalla trama della tragedia illustravano lo spartito canto-piano dell’opera edito da Sonzogno e il manifesto della rappresentazione fu realizzato da Plinio Nomellini con un’immagine che diventerà notissima.
L’accoglienza fu cordiale, ma contrastata, e l’opera, fu giudicata unanimemente troppo lunga. Mascagni rispose alle critiche nel modo più sbagliato, omettendo l’intero quarto atto e molti altri passi dell’opera sino dalla seconda rappresentazione. D’Annunzio non fu d’accordo e addirittura si parlò di ritirare l’opera, ma Mascagni s’impuntò e decise persino altri tagli disseminati qua e là nel corso degli atti. Il cammino di questa bellissima e complessa partitura, così amputata, non poté essere che molto breve. Con quella decisione, inoltre, Mascagni dette l’impressione di non credere troppo nella validità del suo lavoro dando adito a tutta una serie d’illazioni che sono giunte fino a noi.
E il rapporto fra Mascagni e D’Annunzio finì addirittura in tribunale poiché il poeta, nel 1922, decise di rappresentare “Parisina” senza la musica di Mascagni, decisione alla quale il musicista, invano, tentò di opporsi..
Due mesi più tardi, il 19 febbraio 1914, a Torino, Teatro Regio, andava in scena “Francesca da Rimini” di Riccardo Zandonai.
La tragedia di D’Annunzio risaliva al 1901 ed aveva segnato il punto più alto della “collaborazione” con Eleonora Duse.
Con il trentenne Riccardo Zandonai, ancora poco noto, D’Annunzio si era comportato in modo scostante, affidando a Tito Ricordi il compito di ridurre il suo smisurato testo alle dimensioni di un pur ampio libretto d’opera e rifiutando d’incontrare il giovane musicista. Il povero Zandonai fu costretto a fare anticamera persino il giorno in cui D’Annunzio accondiscese a sostituire i versi della sterile “descrizione di Firenze” che nella tragedia si trova durante l’incontro “galeotto” del terzo atto (“Io fui talvolta/ nella casa di un sommo cantatore/ nominato Casella,/ e quivi convenivano taluni/ gentili uomini: Guido Cavalcanti/ tra gli altri, cavaliere de’ migliori,/ che si diletta del dire parole/ per rima, e Ser Brunetto/ dottissimo rettorico/ tornato di Parigi; e un giovinetto/ degli Alighieri nominato Dante”), con quelli, splendidi, del tormento notturno di Paolo, “nemica ebbi la luce/ amica ebbi la notte”, usciti nel volgere di poche ore dal calamo del divino Gabriele.
Alla “Francesca da Rimini” di Zandonai arrise nondimeno un successo notevolissimo destinato a soppiantare quello della sola tragedia dannunziana. E probabilmente il Vate, come suol dirsi, se la legò al dito, rifiutando per sempre di assistere ad una rappresentazione della “Francesca da Rimini” di Zandonai.
C’è da dire che D’Annunzio fu ancora più scostante nei confronti di Gianfrancesco Malipiero. Al prolifico musicista veneziano egli, nonostante qualche promessa, mai concesse i diritti sul “Sogno di un tramonto d’autunno”, opera costretta a rimanere inedita ad onta di un’indubbia qualità musicale, di un’invidiabile speditezza narrativa e di un’asciuttezza degna di grandi momenti novecenteschi. La partitura di Malipiero, conclusa nel 1915, fu eseguita solo il 4 ottobre 1963 alla Rai di Milano (direttore Nino Sanzogno), ironia delle cose, in occasione del centenario della nascita di D’Annunzio, che in qualche modo l’aveva rifiutata.
Se non al lavoro di Zandonai e Malipiero, l’attenzione del Poeta era invece rivolta tutta a quello d’Ildebrando Pizzetti che stava componendo “Fedra”, al punto di suggerire inascoltati consigli sulle novità musicali che giungevano a Parigi, segnatamente “Le sacre du Printemps” di Stravinskij che aveva portato D’Annunzio all’entusiasmo. Pizzetti, fece di testa sua attingendo invece alla ormai consueta fonte wagneriana (nel pur efficace finale dell’opera si ode l’eco della Liebestod tristaniana) e “Fedra” andò in scena il 20 marzo 1915 alla Scala, direttore lo strepitoso Gino Marinuzzi. All’opera arrise un successo cordiale, e Carlo Gatti ancora una volta annotò: “Il pubblico della Scala dimostra di apprezzare i pregi della “Fedra”. Lo stanca, però, poiché non c’è avvezzo, il declamato posto a fondamento del discorso cantato dei personaggi. La “Fedra” insomma restaura nell’opera di musica italiana la sovranità della poesia”. Frase veramente sibillina perché insieme ai generici “pregi” dell’opera Gatti riporta la “stanchezza” del pubblico.
Potremmo dire che la grande stagione dell’opera dannunziana si conclude con la fine della prima guerra mondiale. Il 3 novembre 1918 va in scena alla Scala, in un indescrivibile entusiasmo, “La Nave” di Italo Montemezzi. Nel pomeriggio, si era ovunque diffusa la notizia che una nave italiana, il cacciatorpediniere “Audace”, aveva gettato l’ancora nel porto di Trieste, segnando di fatto la fine delle ostilità con l’Austria e la vittoria italiana.
L’opera fu ascoltata con grande attenzione e applaudita caldamente. Per di più contiene bei pezzi: il preludio, il lamento di Basiliola, il corteo del Principe del Mare, il duetto d’amore, la perorazione della protagonista e l’alleluja finale. L’allestimento è perdipiù fantasmagorico. Il triestino Guido Marussig ha preparato i bozzetti per una scenografia mozzafiato ove campeggia la costruzione di una nave al vero, di nove metri, qualcosa che poi ritroveremo al Vittoriale con la prora dell’incrociatore “Puglia”. Tanta meraviglia, tuttavia, non riuscì a distaccare l’idea generale che il successo della “Nave” di Montemezzi, più che autentico, meritato, fosse pilotato dall’empito nazionalistico del momento.
E D’Annunzio? Ancora il tempo dell’impresa di Fiume poi per lui sarebbe giunto il momento del ritiro. Dal 1922, anno in cui il “Vate” si ritira nella Villa di Gardone, quella che trasformerà nel Vittoriale, egli sarà un aureo sopravvissuto di se stesso. Non più teatro, non più poesia, non più neppure prosa. Solo qualche tenera rievocazione (“Le dit du sourd et du muet”, il parlare del sordo e del muto, totalmente allusiva della sua condizione finale) nei silenzi delle stanze ombrose fra le attenzioni d’Aelis e della Bàccara e niente altro. Così, lentamente, scese anche l’attenzione attorno alla sua indubitabile arte della parola. E col declino, l’oblio. Non più Mascagni, non più Montemezzi, Franchetti per carità. Solo Zandonai con la sua bella bella “Francesca da Rimini” continua a girare il mondo. Ma ancora per poco. Di lì a qualche anno arriveranno solo critiche. Massimo Mila, Rubens Tedeschi, anche De Sabata, pare. Persino Debussy, la cui qualità musicale è indiscutibile, sarà criticato per le musiche di scena del “Martyre de Saint Sébastien”, quasi che le avesse scritte con la mano sbagliata.
Ildebrando Pizzetti ci riprovò nel 1954 mettendo in musica a sua volta “La figlia di Iorio” (Napoli, Teatro di San Carlo, 4 dicembre, direttore Gianandrea Gavazzeni, protagonista la favolosa Clara Petrella). Opera dignitosa, ispirata, ma fuori tempo massimo. La stagione delle opere nuove era finita. Non farà giro.

















4 comments
Caro Fulvio, come sempre: preciso, compiuto e illuminante.
Grazie.
Grazie Sandro
Grazie Teresa
Condivido con sincero entusiasmo questo affascinante excursus storico. Chapeau all’autore.
Comments are closed.